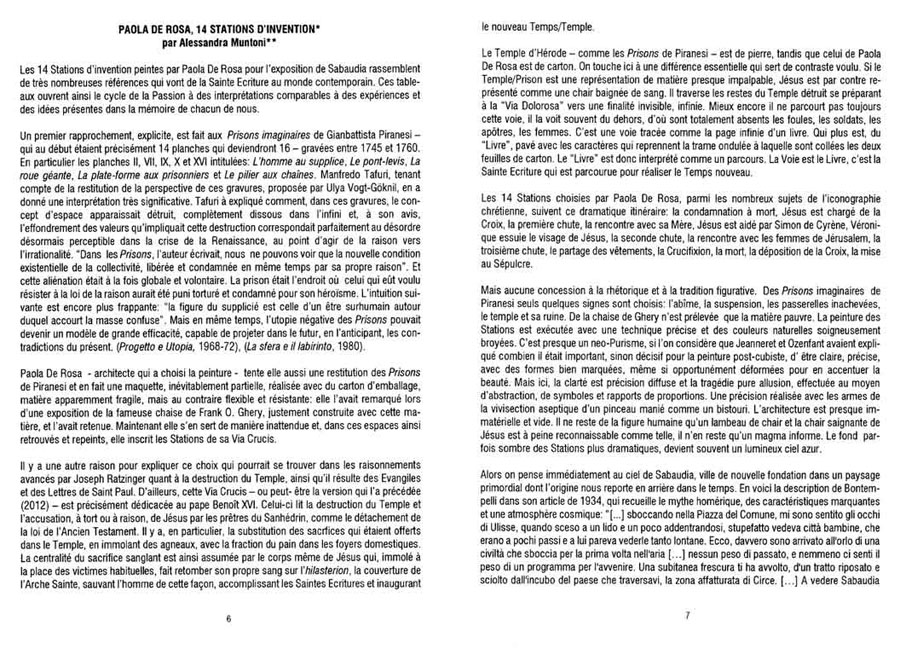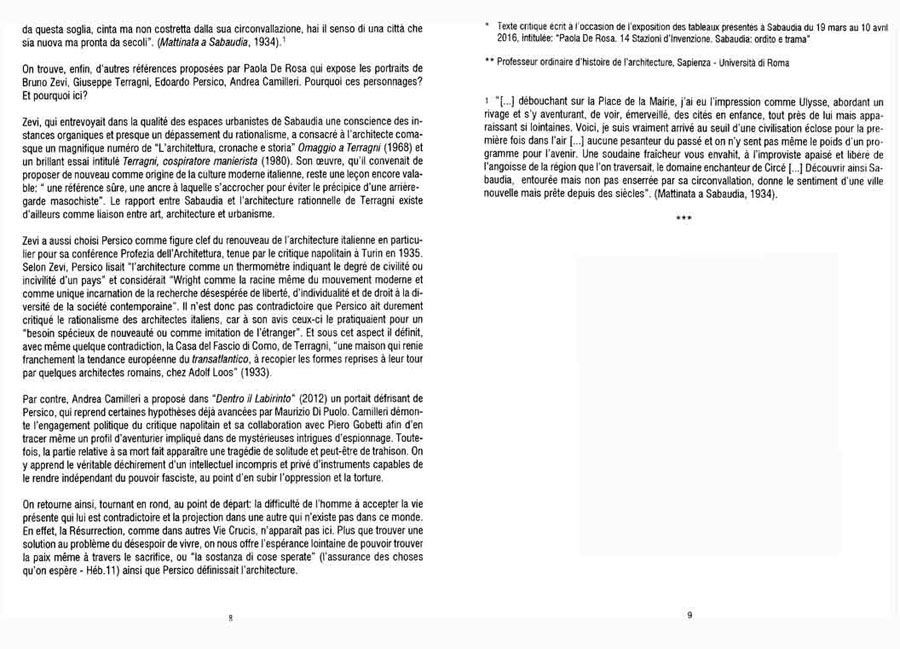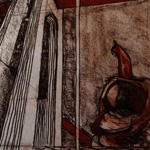Le 14 Stazioni dipinte da Paola De Rosa per la mostra di Sabaudia stringono insieme moltissimi riferimenti che, a partire dalle Scritture, rimandano al mondo contemporaneo. Esse aprono così il ciclo della Passione a interpretazioni che possono essere misurate con esperienze e significati presenti nella memoria di ciascuno di noi.
Un primo riferimento è quello, esplicito, alle Carceri d'Invenzione di
Giambattista Piranesi - che all'inizio erano appunto 14 tavole, poi
diventeranno 16 - incise tra il 1745 e il 1760 . In particolare alle tavole II,
VII, IX, X e XVI intitolate L'uomo sulla roccia, Il ponte levatoio, La ruota
gigante, I prigionieri sulla piattaforma e Il muro con le catene. Manfredo
Tafuri, tenendo conto della restituzione prospettica che di quelle incisioni ha
proposto Ulya Vogt-Göknil, ne ha dato una interpretazione di grande pregnanza.
Egli ha spiegato come in esse il concetto di spazio risultasse distrutto,
addirittura dissolto nell'infinito e, a suo avviso, il crollo dei valori che
quella distruzione implicava corrispondeva alla totalità del disordine ormai
percepibile nella crisi del Rinascimento, tanto che non si potesse che procedere
dalla ragione verso l'irrazionalità. “Nelle Carceri, scriveva, non
possiamo vedere che la nuova condizione esistenziale della collettività,
liberata e dannata ad un tempo dalla sua stessa ragione”. E questa alienazione
era insieme globale e volontaria. Il carcere era il luogo dove chi avesse
voluto resistere alla legge della ragione sarebbe stato punito con la tortura e
il suo eroismo condannato. Ancor più colpisce questa intuizione:“ la figura del
torturato è un essere superumano intorno al quale si affolla la massa
indistinta” . Allo stesso tempo, però, l'utopia negativa delle Carceri
poteva diventare un modello di grande efficacia, in quanto capace di proiettare
nel futuro, anticipandolo, le contraddizioni del presente. (Progetto e
utopia, 1968-72), (La sfera e il Labirinto, 1980).
Paola De Rosa - architetto che ha scelto la pittura - tenta anch'essa una
restituzione delle Carceri del Piranesi, e ne fa un plastico, per forza
di cose un frammento. Lo realizza in cartone da imballaggio, materiale apparentemente
fragile, ma invece flessibile e resistente: lo aveva notato in una mostra che
esibiva la famosa sedia di Frank O. Gehry costruita appunto con quel materiale
e lo aveva tenuto a mente. Ora se ne serve in modo imprevedibile e, in quegli
spazi così ritrovati e ridipinti, inserisce le Stazioni della sua Via Crucis.
C'è un'altra ragione con la quale può essere spiegata questa scelta, e può
trovarsi nei ragionamenti proposti da Joseph Ratzinger a proposito della
distruzione del Tempio, così come emerge dai Vangeli e dalle lettere di Paolo.
Del resto, questa Via Crucis - o forse la versione che l'ha preceduta (2012) -,
è dedicata proprio a Papa Benedetto XVI. Egli legge la distruzione del Tempio,
per il quale Gesù è, a torto o a ragione, accusato dai sacerdoti del Sinedrio,
come l'allontanarsi dalla legge del vecchio Testamento. In particolare c'è la
sostituzione dei sacrifici che nel Tempio venivano fatti, immolando agnelli,
con lo spezzare il pane nelle case. La centralità del sacrificio cruento, però,
viene assunto proprio dal corpo di Gesù che, immolato in vece delle consuete
vittime, fa ricadere il proprio sangue sull'hilasterion, la copertura
dell'Arca Santa, salvando in tal modo l'uomo, compiendo le Sacre Scritture e
inaugurando il nuovo Tempo/Tempio.
Il Tempio di Erode - come le Carceri di Piranesi - è però di pietra,
mentre quello di Paola De Rosa è di cartone. Qui si coglie una sostanziale
differenza che serve per un contrasto voluto. Se il Tempio/Carcere è
rappresentazione di materia quasi impalpabile, Gesù è invece rappresentato come
carne grondante sangue. Egli attraversa i frammenti del Tempio distrutto
avviandosi per la “via dolorosa” verso una meta non visibile, infinita. Anzi
non percorre sempre quella via, spesso la vede dal di fuori, nell'assenza
assoluta delle turbe, dei soldati, degli apostoli, delle donne. È una via
tracciata come la pagina infinita di un libro. Anzi, del “Libro”, lastricato
coi caratteri che riprendono la trama ondulata alla quale i due fogli di
cartone sono incollati. Il Libro è interpretato, dunque, come percorso. La Via
è il Libro, è la Sacra Scrittura che viene percorsa per realizzare il nuovo
Tempo.
Le 14 Stazioni scelte da Paola De Rosa, tra le tante proposte nella iconografia
cristiana, seguono questo drammatico itinerario: la condanna a morte, Gesù è
caricato della Croce, la prima caduta, l'incontro con la Madre, Gesù è aiutato
dal Cireneo, la Veronica asciuga il volto di Gesù, la seconda caduta, incontro
con le donne di Gerusalemme, la terza caduta, la spoliazione delle vesti, la Crocifissione,
la morte, la deposizione dalla Croce, la collocazione nel Sepolcro.
Nulla, però, è concesso alla retorica e alla tradizione figurativa. Dalle Carceri
d'invenzione di Piranesi sono colti alcuni segni: l'abisso, la sospensione, le
passerelle troncate, il Tempio e la sua rovina. Dalla sedia di Gehry è
prelevato il materiale povero. La pittura delle Stazioni è eseguita con una
tecnica precisa, con colori naturali attentamente macinati. È quasi un
neo-Purismo, se Jeanneret e Ozenfant avevano spiegato come fosse importante,
anzi decisivo per la pittura post-cubista, di essere chiara, precisa, con forme
ben delineate, seppure opportunamente deformate per accentuarne la bellezza.
Qui, però, la chiarezza è precisione soffusa e la tragedia è pura allusione,
attuata per via di astrazione, simbologie e rapporti proporzionali. Una
precisione attuata con le armi della vivisezione asettica di un pennello
adoperato come un bisturi. L'architettura è quasi immateriale e vuota. Della
figura umana resta solo un lacerto e la carne sanguinante di Gesù è appena
riconoscibile come tale, ne resta solo una magma informale. La gamma cromatica
è ridotta al minimo. Lo sfondo, talvolta scuro nelle Stazioni più drammatiche,
diventa spesso un luminoso cielo azzurro.
E allora viene subito in mente il cielo di Sabaudia, città di fondazione in un
paesaggio primigenio che ci riporta indietro nel tempo. Eccone la descrizione
di Bontempelli nel suo articolo del 1934, ove si mescolano mito omerico, forme
stagliate e atmosfera cosmica: “[...] sboccando nella Piazza del Comune, mi
sono sentito gli occhi di Ulisse, quando sceso a un lido e un poco
addentrandosi, stupefatto vedeva città bambine, che erano a pochi passi e a lui
pareva vederle tanto lontane. Ecco, davvero sono arrivato all'orlo di una
civiltà che sboccia per la prima volta nell'aria […] nessun peso di passato, e
nemmeno ci senti il peso di un programma per l'avvenire. Una subitanea frescura
ti ha avvolto, d'un tratto riposato e sciolto dall'incubo del paese che
traversavi, la zona affatturata di Circe. […] A vedere Sabaudia da questa
soglia, cinta ma non costretta dalla sua circonvallazione, hai il senso di una
città che sia nuova ma pronta da secoli”. (Mattinata a Sabaudia, 1934).
Ci sono, infine, altri riferimenti proposti dalla stessa De Rosa: Bruno Zevi,
Giuseppe Terragni, Edoardo Persico, Andrea Camilleri, dei quali sono esposti
quattro ritratti. Perché questi personaggi? E perché qui?
Zevi, che intravvedeva nella qualità degli spazi urbanistici di Sabaudia una
coscienza delle istanze organiche e quasi un superamento del razionalismo, ha
dedicato all'architetto comasco un magnifico numero di «L'architettura,
cronache e storia», Omaggio a Terragni (1968) e un saggio illuminante
intitolato Terragni, cospiratore manierista (1980). La sua opera,
sostiene, che era doveroso riproporre come germe della cultura moderna
italiana, resta una lezione tuttora valida: “un riferimento sicuro, un'ancora
cui afferrarsi per evitare il precipizio di una masochistica retroguardia”. Il
nesso tra Sabaudia e l'architettura razionale di Terragni suona del resto come
vincolo tra arte, architettura e urbanistica.
Anche Persico è scelto da Zevi come figura chiave del rinnovamento
dell'architettura italiana, in particolare per la conferenza Profezia
dell'Architettura, tenuta dal critico napoletano a Torino nel 1935. Secondo
Zevi, Persico leggeva “l'architettura come un termometro del grado di civiltà o
inciviltà di un Paese” e considerava “Wright come la radice stessa del
movimento moderno e come incarnazione unica della disperata ricerca di libertà,
individualità, e diritto alla diversità della società contemporanea”. Non è
allora contraddittorio che Persico avesse criticato duramente il razionalismo
degli architetti italiani, perché a suo avviso essi lo stavano praticando per
un “bisogno artificioso di novità o come imitazione dall'estero”. E, in questa
luce, seppure con qualche contraddizione, anche la Casa del Fascio di Como di
Terragni è da lui definita “una casa che rinnega francamente la tendenza
europea del transatlantico, a ricalcare le forme che alcuni architetti
romani hanno ripreso, a loro volta, da Adolf Loos” (1933).
Andrea Camilleri ha proposto, invece, in Dentro il labirinto (2012), un
ritratto demitizzante di Persico, riprendendo alcune ipotesi già avanzate da
Maurizio Di Puolo. Del critico napoletano smonta l'impegno politico e il suo
coinvolgimento con Piero Gobetti, per tratteggiarne addirittura un profilo da
avventuriero implicato in misteriose trame spionistiche. Nella parte relativa
alla sua morte, però, emerge una tragedia di solitudine e forse di tradimento.
Vi si legge la vera e propria lacerazione di un intellettuale incompreso e
privo di strumenti capaci di renderlo autonomo dal potere fascista, tanto da
subirne la sopraffazione e la tortura.
Si ritorna così, circolarmente, al punto di partenza: la difficoltà dell'uomo
di accettare la vita contraddittoria a lui contemporanea e la proiezione in
un'altra che qui non c'è. La Resurrezione, come in altre Vie Crucis, qui
infatti non appare. Più che risolvere la disperazione del vivere, ci si offre
la speranza lontana di poter raggiungere la pace sia pure attraverso il
sacrificio - o “la sostanza di cose sperate” come Persico definiva
l'architettura.
Febbraio 2016
Alessandra Muntoni
Professore Ordinario in Storia dell'Architettura alla Facoltà di
Architettura della Sapienza di Roma.